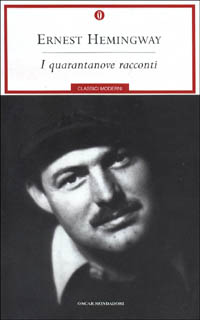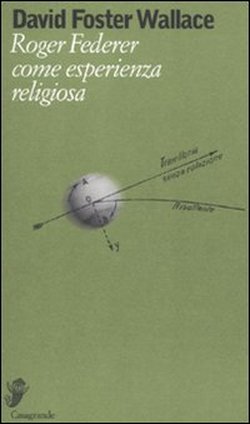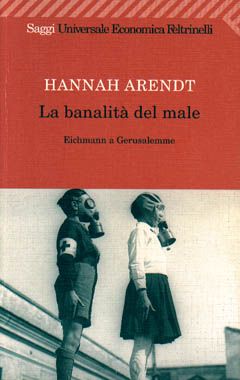Per tutti quelli che hanno ancora una visione romantica del comprare dischi e libri, per tutti quelli che amano gli edifici fatti di musica e parole, con pareti di carta e colonne di dischi e musicassette. E per tutti i Davide che osano sfidare i Golia.
Archivi tag: libri
Passi d’autore #12: John Fante
 Il caldo di mezzogiorno mi prese al collo appena fuori dalla Chevy e mi diressi verso un raduno di uomini sotto la pergola d’uva. Erano in sei, raccolti intorno a un tavolo da picnic, Angelo a un capo, mio padre all’altro. Maestosamente piegato, il mio vecchio giaceva su una sedia di vimini, sbronzo fradicio, con le braccia abbandonate sui braccioli. Era come un patrizio dell’antica Roma in attesa che il sangue finisse di scorrere dai suoi polsi incisi. Uno davanti all’altro, seduti su panche, c’erano i quattro zoticoni del Café Roma: Zarlingo, Cavallaro, Antrilli e Benedetti. Erano tutti strafatti, ma sotto controllo, e tracannavano da grossi boccali. Sul lungo tavolo erano sparsi boccioni di vino e vassoi di roba da mangiare: salame, salsicce, prosciutto, pane e pasticciotti all’anice. Avevano banchettato a lungo e bene nel gran caldo della vigna, e così avevano fatto sciami di vespe inebetite, che svolazzavano sul cibo e annaspavano in qualche pozza di vino, mentre altre centinaia ronzavano tristemente tra i grappoli troppo maturi di uva moscatella che pendevano dalla vigna.
Il caldo di mezzogiorno mi prese al collo appena fuori dalla Chevy e mi diressi verso un raduno di uomini sotto la pergola d’uva. Erano in sei, raccolti intorno a un tavolo da picnic, Angelo a un capo, mio padre all’altro. Maestosamente piegato, il mio vecchio giaceva su una sedia di vimini, sbronzo fradicio, con le braccia abbandonate sui braccioli. Era come un patrizio dell’antica Roma in attesa che il sangue finisse di scorrere dai suoi polsi incisi. Uno davanti all’altro, seduti su panche, c’erano i quattro zoticoni del Café Roma: Zarlingo, Cavallaro, Antrilli e Benedetti. Erano tutti strafatti, ma sotto controllo, e tracannavano da grossi boccali. Sul lungo tavolo erano sparsi boccioni di vino e vassoi di roba da mangiare: salame, salsicce, prosciutto, pane e pasticciotti all’anice. Avevano banchettato a lungo e bene nel gran caldo della vigna, e così avevano fatto sciami di vespe inebetite, che svolazzavano sul cibo e annaspavano in qualche pozza di vino, mentre altre centinaia ronzavano tristemente tra i grappoli troppo maturi di uva moscatella che pendevano dalla vigna.
Non una parola fu pronunciata allorché mi unii a loro. Era come se io non avessi alcuna importanza, come se fossi solo una piccola seccatura, un’altra vespa. Piano piano, mi piazzai dietro la sedia di mio padre e gli misi le mani sulle spalle, sentendo la sua carne morbida che cedeva e le ossa così vicine al tatto.
– Sono io, papà. – Lui alzò la testa.
– Che ora è?
– E’ ora che torni in ospedale.
– Nossignore. Neanche per idea.
– Hai bisogno dell’insulina. – Scosse il capo.
– Finiscila di tormentare tuo padre – disse Zarlingo. – Siediti, bevi una cosa. E sta’ tranquillo. Goditi la festa.
– Lo riporto all’ospedale.
– E’ lui che deve decidere. – Si sporse e toccò la mano di mio padre. – Ci vuoi tornare all’ospedale, Nick?
– No, Joe. Qui si sta bene. C’è pace.
L’afono Angelo emise un suono e mi fece cenno di andargli vicino, allettandomi con un sorriso senza denti. Come mi fui spostato, cominciò a scrivere qualcosa con la matita su un blocchetto di fogli; scriveva rapidamente, incidendo la carta, e poi strappò il foglio e me lo porse.
Era leggibile, ma era scritto in italiano.
– Non capisco – dissi, restituendoglielo.
Benedetti me lo scippò. – Fammi vedere.
Esaminò lo scritto per un momento, quindi fece larghi cenni d’approvazione all’indirizzo del vecchio. – Giusto – disse ad Angelo. – Hai sempre ragione, Angelo.
– Che dice? – domandai.
– Dice: << E’ meglio morire di bevute che morire di sete>>. – Spostai lo sguardo da lui al vecchio vignaiolo.
– E che cosa vorrebbe dire? – chiesi, fissando gli occhi sfatti di Angelo. – Non capisco.
Prontamente, Angelo si rimise a scrivere: un’altra frase all’impronta. Poi passò il foglio a Benedetti, che tradusse di nuovo.
– <<Meglio morire tra amici che morire tra i dottori>>.
Ci fu un applauso, un battimani, e calici levati per un brindisi e subito vuotati; fece un gesto anche mio padre, il quale era al di là della soglia in cui non si capisce più nulla.
Incoraggiato, Angelo si rimise a scrivere un’altra volta. Per quanto mi riguardava, c’era una sola cosa da fare. Tirai indietro la sedia di mio padre e cercai di sollevarlo, mettendogli le braccia attorno al petto. Lui si dibatteva, debolmente ma con accanimento, contorcendosi per rimanere seduto. I “paisani” osservavano. Non mi avrebbero aiutato.
– Per favore – dissi – qualcuno mi dia una mano. Quest’uomo è molto malato.
Loro rimasero immobili come sepolcri. Mi misi a piangere, non di dolore, non di angoscia per la sorte di mio padre, ma autocompatendomi. Com’ero buono. Che bravo figlio leale! Guardatemi, sto cercando di salvare la vita a mio padre. E com’ero orgoglioso di me. Che impeccabile essere umano ero!
Piansi e battei i pugni sul tavolo, e il vino s’agitò e zampillò fuori e le vespe si risentirono. Mi strappai i capelli. Caddi in ginocchio e abbrancai mio padre. – Vieni con me, papà! Hai bisogno di cure. Non devi morire in questo posto sciagurato.
Il suo sguardo svagato riuscì a trovarmi.
– Va’ a casa ragazzo. Vedi un po’ che vuole mamma.
Mi alzai, pieno di vergogna e di nausea, e poi presi posto sulla panca, singhiozzando. Avevo un mio talento per i pianti. Mi aveva procurato svariati riconoscimenti nel corso della vita, e anche qualche fastidio. Quando le tue debolezze sono la tua forza, che fai? Piangi. Dal momento che il pianto semina sconcerto, la gente non sa come prenderla; sono lì che magari si aspettano un’esplosione di violenza e d’un tratto tutto svanisce in una pozza di lacrime. Piansi alla prima comunione. Le mie lacrime ebbero ragione di Harriet e così alla fine mi sposò. Senza lacrime non avrei mai potuto sedurre una donna; con le lacrime non mi andò mai buca. Era una cosa che devastava il cuore delle donne alle quali non andavo a genio e che, in seguito, avrebbero voluto uccidermi perché le avevo fatte soccombere. Piangevo persino mentre scrivevo cose melanconiche. E più invecchiavo, più piangevo.
E ora Zarlingo s’era commosso e si era sporto per stringermi una mano. – Calmati, figliolo – mi consolò. – Asciugati gli occhi, bevi qualcosa. Non ti preoccupare per tuo padre. E’ forte come un bue.
Mi strofinai il viso e mi soffiai il naso. Mandai giù un sorso di vino. Dalla statale, in basso, venne l’urlo di una sirena: sempre più vicino, sempre più alto.
(da La confraternita dell’uva, 1977. Traduzione di Francesco Durante)
Giallo di Francia
Luglio è il mese del Tour de France. Quest’anno lo si corre per la centesima volta ed è sempre un gran bello spettacolo, specie se per un attimo si evita di pensare all’affaire Armstrong, ai dubbi sul trionfo di Pantani del ’98 sollevati dall’Uci, e al fatto che Froome ha già ipotecato la vittoria finale, a meno di sorprese clamorose, tipo un’impresa d’altri tempi di Contador o una giornata nerissima del britannico della Sky.
Mercoledì, per esempio, si è disputata una cronometro individuale con arrivo a Mont Saint-Michel che è stata una delizia per gli occhi.
A proposito di delizie, quando Gianni Mura parla di cibo bisogna togliersi il cappello, come si fa in chiesa. Il 7 è stato ospite di Tour Replay, la rubrica d’approfondimento di Rai Sport che va in onda subito dopo la telecronaca delle singole tappe: dopo essersi professato pirenaico, “perché le le Alpi sono le montagne dei ricchi, mentre i Pirenei sono le montagne dei poveri e hanno bisogno di una mano”, Mura si è esibito in un breve saggio gastronomico che vale la pena riportare per intero (rai.tv, dal minuto 22:10 a 25:00 circa).
Auro Bulbarelli
Vorrei chiedere a Gianni Mura, che è uno dei più grandi esperti non solo di ciclismo ma anche di cucina e di cose buone: cosa, a te personalmente, piace di più mangiare quando sei in questa zona, nel sud della Francia? (Bagnères-de-Bigorre, regione dei Midi-Pyrénées, parte dell’antica Linguadoca)
Gianni Mura
Mah, a una quindicina di chilometri dal traguardo c’è un paesino minuscolo dove c’è un ottimo ristorante che fa per esempio un piatto che faceva mia nonna, l’ho scoperto, ed è l’omelette, la frittata anzi, con dei pezzi di salame, che nel pavese si chiama “frittata rognosa”. Lo chef insiste anche per metterci dei pezzi di porcino ma su questo abbiamo avuto una discussione.
Bulbarelli
Ma il salame viene cotto prima o a crudo?
Mura
Il salame viene messo a un certo punto della cottura. Ed è anche una zona, quella, dove si fa… i francesi non sanno lavorare bene il maiale, secondo me, è una delle colpe maggiori che hanno ai miei occhi. E questa zona è una delle poche in cui si mangiano dei salami decenti; ovviamente la razza (del maiale) è il Noir de Bigorre […]
Stuzzicato dal conduttore, Mura passa dalla frittata rognosa al cassoulet.
Castelnaudary è una delle patrie (del cassoulet) perché un’altra è Tolosa e un’altra è Carcassonne, ma secondo me non è vero, io considererei Castelnaudary e Tolosa.
Bulbarelli
Beh, spieghiamo anche cos’è questo cassoulet.
Mura
Per gli italiani del nord: è come una cassoeula, solo che la cassoeula ha la verza, il cassoulet ha i fagioli bianchi, possibilmente della varietà “coco de Tarbes”, in Francia, qui (in Italia) vanno bene quelli della Val Nervia. Ed è un piatto di resistenza, una volta si faceva la domenica e durava 2-3 giorni […] In pratica sono fagioli bianchi […] con pezzi di maiale, salsicce, altri ci mettono maiale e anitra, dipende, questa è la differenza tra Tolosa e Castelnaudary, o pezzi d’oca, insomma… E’ un piatto di una pesantezza mostruosa, mangiarlo durante il Tour è una prova di coraggio, un po’ com’era una volta attraversare i fiumi a nuoto, specie se fa molto caldo; se fa freddo si può, insomma… il cassoulet è un piatto che comunque consente di stare molto a tavola…
Per anni Mura ha raccontato il Tour sulle pagine di Repubblica, ma pare che quest’anno gli appassionati dovranno fare a meno della sua penna. Io mi accontenterei di vederlo ogni giorno ospite di Tour Replay. Nel frattempo mi consolo con le vecchie corrispondenze, quelle scritte dall’alter ego di Mura in Giallo su giallo (Universale Economica Feltrinelli, 2007), prima avventura letteraria del giornalista milanese. Un libro che ha diversi piani di lettura. E’ un giallo, innanzitutto: c’è un serial killer che insanguina le strade della Grande Boucle e un commissario di nome Magrite – Mura gioca con Simenon e il surrealismo – che gli dà la caccia. E’ giornalismo sportivo all’ennesima potenza (il romanzo contiene la cronaca dettagliata del Tour 2005). E’ un trattato enogastronomico e al contempo il ritratto fedele di un giornalista in trasferta, il racconto di come si svolge la giornata di un inviato che giorno per giorno si sposta attraverso la Francia al seguito della carovana gialla, di città in città, di albergo in albergo, di ristorante in ristorante e, mi permetto di aggiungere, di piatto in piatto (c’è pure il cassoulet, fra gli altri).
Un mistero diverso avvolge invece Appuntamento a Belleville, film d’animazione del 2003 diretto dal disegnatore francese Sylvain Chomet (La vieille dame et les pigeons, L’illusionista). Siamo di nuovo al Tour e dentro il mondo del ciclismo, almeno per metà film, ma questa volta il protagonista della storia non è un giornalista sportivo e nemmeno un detective, bensì un giovane ciclista di nome Champion che ha il naso aquilino di Fausto Coppi. Champion è un orfano che cresce infelice nel ricordo dei genitori scomparsi, sotto l’ala protettrice della nonna, Madame Souza. Questo ricordo si condensa in una fotografia che ritrae mamma e papà in bici, una foto che Champion guarda di continuo. La vecchietta prova in ogni modo a regalare un po’ di gioia al nipotino ma i suoi sforzi si rivelano sempre vani, finché scopre la foto e capisce che forse un triciclo potrebbe aiutare Champion a trovare il sorriso. E’ così che nel bambino esplode una passione smodata per la bicicletta, che dopo duri allenamenti lo porterà a gareggiare al Tour de France. Ma nel bel mezzo della corsa, Champion viene rapito da alcuni loschi figuri e condotto a forza dall’altra parte dell’oceano, nella città immaginaria di Belleville. Toccherà a Madame Souza e al fedele cane Bruno intraprendere un lungo viaggio pieno di peripezie alla ricerca dello sfortunato ragazzo.
Stento a definirlo un giallo, si tratta piuttosto di una favola scoppiettante dall’atmosfera retrò, puntellata da spassosi intermezzi musicali che suppliscono all’assenza di dialoghi. Da vedere soprattutto per la qualità del disegno e per gli incubi in bianco e nero del cane Bruno, che sono la trovata migliore di tutto il film.
Chiudo in musica con Jannacci padre e figlio e con un classico dei Kraftwerk. In realtà, al posto di quest’ultimo pezzo, avrei preferito pubblicarne un altro, ma nel video ci sono troppe donnine nude, non sia mai che qualcuno si scandalizzi. Mi sono autocensurato.
Turpiloqui
Dopo gli ultimi sexgate all’italiana emersi di recente (Comune di Firenze e Regione Sicilia), in tanti ora pretendono le pubbliche scuse della folta schiera di politici che nel marzo scorso ha crocifisso Battiato per quella frase, ormai celebre, pronunciata nel corso di un intervento all’assemblea di Bruxelles.
“Nel parlamento italiano ci sono troie disposte a tutto”, così parlò l’asceta di Milo.
Senza voler azzardare l’esegesi di tale affermazione, secondo me quella di Battiato è stata comunque un’uscita infelice, che da un lato mi ha sorpreso, dall’altro confortato. Sorpreso perché da lui un linguaggio così sboccato non te l’aspetti. Non te l’aspetti da un cantautore che è riuscito a infilare nelle sue canzoni tutti i lemmi più inutilizzati del vocabolario italiano senza perdere mai l’equilibrio, senza coprirsi di ridicolo come sarebbe accaduto al 99% dei cantanti italiani, e quel che più conta, continuando a vendere dischi. Confortato perché scoprire che anche i mistici s’incazzano e dicono le parolacce fa riconciliare con se stessi. E anche perché temevo che, presto o tardi, dopo anni trascorsi a meditare nel buen retiro alle pendici dell’Etna, Battiato si sarebbe librato verso i sereni cieli dell’estasi pura, che nessuna misera questione mortale può turbare. E invece io lo voglio qui fra noi, saldamente agganciato alla terra, a scrivere ancora musica per le nostre orecchie, partecipe delle sorti di questa stupida Italietta.
A pensarci bene, però, almeno in un’altra occasione Battiato si è lasciato andare al turpiloquio, stavolta non per esasperazione, ma per aver dato retta a Manlio Sgalambro.
Ecco com’è che va il mondo, settima traccia de L’imboscata (1996)
Non prostituta, escort, lucciola, peripatetica, donna di piacere, bella di notte, cortigiana, cocotte. No, proprio puttana, una schifosa montagna di grasso. Attacco degno del più sordido Bukowski, e invece trattasi di Hemingway, quello dei 49 racconti (Oscar Mondadori, 2001).
La luce del mondo è come un quadro di Hopper: stessa inquietudine che scorre sottotraccia, stesse atmosfere misteriose, stessa sensazione di pericolo incombente.
Dopo aver rischiato di prendere una schioppettata da un barista coi nervi a fior di pelle, una coppia di giovani amici entra nella sala d’aspetto di una stazione, dove in assoluto silenzio siedono quattro indiani, sei uomini bianchi e cinque puttane. Uno degli uomini bianchi è un cuoco, non ho ancora ben capito se omosessuale o soltanto effeminato, gli altri sono soprattutto boscaioli. Due delle cinque puttane sono grassissime, una terza, di nome Alice, è addirittura enorme. Le due che restano non hanno niente di speciale, se non i capelli biondi ossigenati. L’ingresso dei ragazzi infrange il silenzio della sala e dà l’abbrivio alla conversazione; solo gli indiani non fiatano. Finché il discorso cade su un grande pugile, morto ammazzato dal padre, e si accende un battibecco fra Alice e una delle bionde ossigenate. La bionda sostiene di essere stata l’amante del pugile, un uomo di gran classe ed eleganza; Alice ribatte che no, la bionda non è mai stata l’amante del pugile, un balordo qualsiasi. Nonostante l’incredibile stazza, Alice è la più bella di tutte. Ha una voce suadente, la pelle liscia, è simpatica e ride di continuo, con una risata fragorosa, sussultando come un ammasso di morbida e colorata gelatina. Uno dei due ragazzi, la voce narrante, la scruta rapito.
Sgalambro scrisse un testo basato su questa storia e propose a Battiato di musicarlo e interpretarlo. In un primo momento il compositore siciliano rifiutò, per poi cedere all’insistenza dell’amico filosofo, trasformando quelle ruvide parole in una tenera ballata sullo scorrere del tempo.
Dedicato a Gesualdo Bufalino, L’imboscata è un album così così, una tappa interlocutoria nella carriera artistica di Battiato, che a metà anni ’90 sente il bisogno dell’ennesima svolta musicale e torna ad imbracciare la chitarra elettrica. Ne viene fuori un rock “duro” che però subisce ancora l’influsso dei dischi precedenti e quasi prefigura il più compiuto Gommalacca (1998), dove a suonare chitarra, basso e batteria sembra esserci un gruppo metallaro. L’imboscata è importante perché stavolta il cantautore siciliano non scrive sui tasti di un pianoforte ma sulle corde di una chitarra elettrica. Per questo e per un’altra ragione: soprattutto grazie a La Cura e a Strani Giorni, canzone in cui l’impianto rock del disco si rende più evidente, Battiato torna al grande successo popolare che aveva già conosciuto negli anni ’80.
Ma di quale imboscata stiamo parlando? Una è quella tesa dal cantautore che con un colpo di coda dei suoi spiazza fan e critica, incidendo un album pieno di venature rock, inaspettato per la fase artistica che stava attraversando. Un’altra ce la indica lo stesso Battiato:
In realtà l’imboscata è questa: dietro le cose apparentemente più semplici ci sono altri piani di lettura, e dietro canzoni pretenziose, che mirano in alto, spesso c’è la pochezza.
Un’altra ancora è quella in cui ha creduto di incappare uno sprovveduto presidente di regione, che si è sentito tradito da un artista notoriamente poco incline a farsi tappare la bocca, il quale prima finge di promettergli che sarà suo servo fedele vita natural durante, solo per farsi nominare assessore regionale alla Cultura, e poi da vero bastardo lo accoltella alle spalle con una frase ingiuriosa sul parlamento italiano.
Scrive Hemingway nella prefazione a I 49 racconti:
[…] In questo libro ci sono racconti di ogni genere. Spero che ne troverete qualcuno che vi piace. Rileggendoli, quelli che mi piacciono di più – a parte i racconti che hanno raggiunto una certa notorietà, per cui gli insegnanti li includono nelle antologie che i loro alunni devono comprare per i corsi di letteratura, e tu leggendoli sei sempre un tantino imbarazzato e ti chiedi se davvero li hai scritti tu o se per caso li hai sentiti in qualche posto – sono La breve vita felice di Francis Macomber, In un altro paese, Colline come elefanti bianchi, Come non sarai mai, Le nevi del Kilimangiaro, Un posto pulito, illuminato bene, e un racconto intitolato La luce del mondo che oltre a me non è mai piaciuto a nessuno. […]
Caro Hemingway, conosco almeno tre persone a cui è piaciuto il tuo racconto su quella puttana bellissima e obesa: c’è Manlio Sgalambro, Franco Battiato e ci sono io.
Passi d’autore #11: Bruce Chatwin
 Al bar, Arkady ordinò due cappuccini. Ci sedemmo a un tavolo vicino alla vetrina, e lui cominciò a parlare.
Al bar, Arkady ordinò due cappuccini. Ci sedemmo a un tavolo vicino alla vetrina, e lui cominciò a parlare.
La rapidità della sua mente mi affascinava, anche se ogni tanto lui mi sembrava un oratore sul palco e le sue parole cose in gran parte già dette.
La filosofia degli aborigeni era legata alla terra. Era la terra che dava vita all’uomo; gli dava il nutrimento, il linguaggio e l’intelligenza, e quando lui moriva se lo riprendeva. La << patria >> di un uomo, foss’anche una desolata distesa di spinifex, era un’icona sacra che non doveva essere sfregiata.
<< Sfregiata da strade, miniere o ferrovie? >>.
<< Ferire la terra >> mi rispose con grande serietà << è ferire te stesso, e se altri feriscono la terra, feriscono te. Il paese deve rimanere intatto, com’era al Tempo del Sogno, quando gli Antenati col loro canto crearono il mondo >>.
<< Rilke ebbe un’intuizione del genere >> ribattei. << Anche lui disse che cantare era esistere >>.
<< Lo so >> disse Arkady appoggiando il mento sulle mani. << Terzo sonetto a Orfeo >>.
Gli aborigeni, proseguì, si muovevano sulla terra con passo leggero; meno prendevano dalla terra meno dovevano restituirle. Non avevano mai capito perché i missionari vietassero i loro innocui sacrifici. Loro non sacrificano vittime, né animali né umane: quando volevano ringraziare la terra dei suoi doni, si incidevano semplicemente una vena dell’avambraccio e lasciavano che il sangue impregnasse il terreno.
<< Non è un prezzo eccessivo >> disse. << Le guerre di questo secolo sono il prezzo che paghiamo per aver preso troppo >>.
<< Ah, certo >> assentii poco convinto. << Ma non potremmo parlare ancora delle Vie dei Canti? >>.
<< Altroché >>.
Ero venuto in Australia per imparare da me, e non dai libri altrui, che cos’erano le Vie dei Canti, e come funzionavano. Naturalmente non sarei arrivato al nocciolo della questione, né intendevo arrivarci. A Adelaide avevo domandato a un’amica se conosceva un esperto, e lei mi aveva dato il numero di telefono di Arkady.
<< Ti spiace se uso il mio taccuino? >>.
<< Fa’ pure >>.
Tirai fuori di tasca un taccuino con la copertina di tela cerata, tenuto chiuso da un elastico.
<< Bello >> commentò.
<< Li compravo a Parigi, ma adesso non li fanno più >>.
<< A Parigi? >> ripeté inarcando un sopracciglio, come se fosse la cosa più snob che avesse mai sentito.
Poi mi strizzò l’occhio e riprese il discorso.
Per afferrare il concetto di Tempo del Sogno, disse, devi considerarlo un equivalente aborigeno dei primi due capitoli della Genesi, con una differenza significativa.
Nella Genesi Dio creò per prima cosa gli << esseri viventi >>, poi con l’argilla plasmò il padre Adamo. Qui in Australia gli Antenati si crearono da sé con l’argilla, migliaia e migliaia, uno per ogni specie totemica.
<< Perciò, quando un aborigeno ti dice: “Io ho un Sogno Wallaby” , intende: “Il mio totem è il Wallaby. Sono un membro del clan Wallaby” >>.
<< Quindi un Sogno è l’emblema di un clan? Un contrassegno per distinguere “noi” da “loro” ? Il “nostro” paese dal “loro” paese? >>.
<< E’ molto di più >> rispose.
Ogni uomo Wallaby credeva di discendere da un Padre Wallaby universale, antenato di tutti gli altri Uomini Wallaby e di tutti i wallaby del mondo. Perciò i wallaby erano suoi fratelli; uccidere uno di loro per cibarsene era sia fratricidio che cannibalismo.
<< Eppure >> insistetti << l’uomo non era un wallaby più di quanto gli inglesi siano leoni, i russi orsi o gli americani aquile >>.
<< Ogni specie >> disse << può essere un Sogno. Anche un virus: ci può essere un Sogno varicella, un Sogno pioggia, un Sogno arancio del deserto, un Sogno pidocchio. Nel Kimberley adesso hanno un Sogno denaro >>.
<< E i gallesi hanno i porri, gli scozzesi i cardi e Dafne fu tramutata in un alloro >>.
<< Sempre la stessa storia >> disse.
Riprese la spiegazione: si credeva che ogni antenato totemico, nel suo viaggio per tutto il paese, avesse sparso sulle proprie orme una scia di parole e di note musicali, e che queste Piste del Sogno fossero rimaste sulla terra come “vie” di comunicazione fra le tribù più lontane.
<< Un canto >> disse << faceva contemporaneamente da mappa e da antenna. A patto di conoscerlo, sapevi sempre trovare la strada >>.
<< E un uomo in walkabout si spostava seguendo sempre una Via del Canto? >>
<< Ai vecchi tempi sì >> assentì. << Oggi viaggia in treno o in automobile >>.
<< E se l’uomo deviava dalla sua Via? >>.
<< Sconfinava. La trasgressione poteva costargli un colpo di lancia >>.
<< E finché restava sulla pista, invece, trovava sempre persone con il suo stesso Sogno? Che erano, di fatto, suoi fratelli? >>.
<< Sì >>.
<< Dai quali poteva aspettarsi ospitalità? >>.
<< E viceversa >>.
<< Perciò il canto è una specie di passaporto e insieme di buono-pasto? >>.
<< Anche qui è più complicato >>.
L’Australia intera poteva, almeno in teoria, essere letta come uno spartito. Non c’era roccia o ruscello, si può dire, che non fosse stato cantato o che non potesse essere cantato. Forse il modo migliore di capire le Vie dei Canti era di pensare a un piatto di spaghetti ciascuno dei quali è un verso di tante Iliadi e Odissee – un intrico di percorsi dove ogni << episodio >> è leggibile in termini geologici.
<< Con “episodio” intendi “luogo sacro” ? >> gli domandai.
<< Esatto >>.
<< Luoghi come quelli di cui stai facendo la mappa per la ferrovia? >>.
<< Mettiamola così >> rispose. << Ovunque nel bush puoi indicare un elemento del paesaggio e domandare all’aborigeno che è con te: “Che storia c’è là?”, oppure: “Chi è quello?”. E lui probabilmente ti risponderà: “Canguro” o “Budgerigar” o “Lucertola”, secondo l’Antenato che passò di lì >>.
<< E la distanza tra due luoghi del genere si può misurare come un brano musicale? >>.
<< Questa >> disse Arkady << è la fonte di tutti i miei guai con quelli della ferrovia >>.
Un conto era persuadere un ispettore che un mucchio di sassi erano le uova del Serpente Arcobaleno o che un monticello di arenaria rossiccia era il fegato di un canguro ucciso da una lancia , un conto era convincerlo che una vuota distesa di pietrisco era l’equivalente musicale dell’Opera 111 di Beethoven.
Gli Antenati, che avevano creato il mondo cantandolo, disse, erano stai poeti nel significato originario di poiesis, e cioè << creazione >>. Nessun aborigeno poteva concepire che il mondo creato fosse in qualche modo imperfetto. La vita religiosa di ognuno di essi aveva un unico scopo: conservare la terra com’era e come doveva essere. L’uomo che andava in walkabout compiva un viaggio rituale: calcava le orme del suo Antenato senza cambiare una parola né una nota – e così ricreava il Creato.
<< Certe volte, >> disse Arkady << mentre porto i “miei vecchi” in giro per il deserto, capita che si arrivi a una catena di dune e che d’improvviso tutti si mettano a cantare. “Che cosa state cantando?” domando, e loro rispondono: “Un canto che fa venir fuori il paese, capo. Lo fa venir fuori più in fretta” >>.
Gli aborigeni non credevano all’esistenza del paese finché non lo vedevano e lo cantavano: allo stesso modo, nel Tempo del Sogno, il paese non era esistito finché gli Antenati non lo avevano cantato.
<< Quindi, se ho capito bene, la terra deve prima esistere come concetto mentale. Poi la si deve cantare. Solo allora si può dire che esiste >>.
<< Esatto >>.
<< In altre parole “esistere” è “essere percepito”? >>.
<< Sì >>.
<< Somiglia pericolosamente alla confutazione della Materia del vescovo Berkeley >>.
<< O al buddhismo della Mente Pura, >> disse Arkady << che vede a sua volta il mondo come illusione >>.
<< Allora quattrocentocinquanta chilometri di acciaio, tagliando in due chissà quanti canti, turberanno di sicuro l’equilibrio mentale dei “tuoi vecchi” >>.
<< Sì e no >> rispose. << Emotivamente sono molto forti, e molto pragmatici. E poi hanno visto di peggio che una ferrovia >>.
Gli aborigeni credevano che tutti gli << esseri viventi >> fossero stati fatti in segreto sotto la crosta terrestre, compreso tutto l’armamentario dell’uomo bianco – i suoi aeroplani, i suoi fucili, le sue Toyota – e ogni invenzione che sarà mai inventata; tutto sonnecchia sotto la superficie in attesa di essere chiamato.
<< Forse >> suggerii << col loro canto potrebbero rispedire la ferrovia nel mondo creato da Dio? >>.
<< Ci puoi scommettere >> disse Arkady.
(da Le Vie dei Canti, 1987. Traduzione di Silvia Gariglio)
La caduta degli dei
 Mi sa tanto che ieri pomeriggio è tramontata un’epoca, quella di Sua Maestà Roger Federer. In verità sono anni che non gioca ai massimi livelli, che nel suo caso sono livelli stratosferici, ma finora, come per magia, sulla sacra erba di Londra lo svizzero aveva sempre ritrovato lo smalto dei tempi migliori, quando era invincibile, Achille piè veloce, e si muoveva lungo il campo con la grazia di Baryšnikov, quando faceva tutto con estrema facilità e naturalezza e ogni colpo scoccava dalla racchetta come un dardo divino, quando il suo tennis sembrava infuso di una purezza ultraterrena e tutti gli altri apparivano come goffi praticanti, piccoli piccoli al suo cospetto.
Mi sa tanto che ieri pomeriggio è tramontata un’epoca, quella di Sua Maestà Roger Federer. In verità sono anni che non gioca ai massimi livelli, che nel suo caso sono livelli stratosferici, ma finora, come per magia, sulla sacra erba di Londra lo svizzero aveva sempre ritrovato lo smalto dei tempi migliori, quando era invincibile, Achille piè veloce, e si muoveva lungo il campo con la grazia di Baryšnikov, quando faceva tutto con estrema facilità e naturalezza e ogni colpo scoccava dalla racchetta come un dardo divino, quando il suo tennis sembrava infuso di una purezza ultraterrena e tutti gli altri apparivano come goffi praticanti, piccoli piccoli al suo cospetto.
Wimbledon è casa sua, anzi, il suo regno, e una sconfitta in 4 set al secondo turno, sul Centre Court, per mano del n. 116 del ranking, somiglia molto a un regicidio. Federer non ha giocato da schifo come mi è capitato di leggere in giro, gli ho visto fare di peggio. Certo, nulla a che vedere con l’alieno di una volta: troppo timido nei momenti decisivi della partita e una quantità assurda (per lui) di stecche. Però il punteggio finale ci dice che ha perso due set allo spareggio e l’altro 7-5, concedendo due break all’avversario, di cui uno subito “controbreccato” . Nel terzo set non ha sfruttato l’unica opportunità di strappare il servizio a Stakhovsky, e se nel quarto fosse entrato quel passante sul set point, forse le cose sarebbero finite in modo diverso. Ma l’ucraino ha coperto bene la rete e il passante non è entrato. E comunque, anche nel bel mezzo della tragedia, Federer è stato capace di illuminare il Centrale con lampi di assoluta meraviglia, come uno smash di rovescio ad incrociare da metà campo, spedito morbidamente sulla riga con un angolo strettissimo, appena oltre la rete, dentro l’area di servizio.
Era da 36 slam che non perdeva prima dei quarti. Niente dura in eterno, nemmeno Roger Federer. In passato ha già attraversato periodi di crisi, ma allora c’era tutto il tempo di riprendersi, aveva l’età dalla sua parte. Invece questo sembra essere definitivo. L’ora dello svizzero è suonata, e se non è il gong che chiude l’incontro, è almeno quello che segna l’inizio dell’ultimo round. Forse avrà ancora modo di vincere qualcos’altro.
Per il momento, quello in corso di svolgimento è il Wimbledon degli infortuni e delle grandi sorprese: fuori Federer, fuori Nadal, fuori Tsonga; fuori Sharapova e Azarenka nel torneo femminile. Djokovic si starà fregando le mani e probabilmente a Murray già tremano i polsi, perché questa potrebbe essere la volta buona che un britannico torni a vincere Wimbledon dopo 77 anni di attesa (l’ultimo è stato Fred Perry, nel 1936). Auguroni, Murray.
Chiudo il post con un video tributo che l’ATP ha pubblicato su YouTube per i dieci anni dal primo trionfo di Federer in quel di Londra. Al video seguono le parole di David Foster Wallace, che avevo messo da parte nella speranza di servirmene per celebrare l’ennesimo record del Campione, il più grande di tutti, l’ottavo Wimbledon in carriera. E invece sono finite dentro una specie di necrologio.
Ci sono tre spiegazioni valide per l’ascesa di Federer. La prima ha a che vedere con il mistero e la metafisica ed è, a mio avviso, la più vicina alla verità. Le altre sono più tecniche e funzionano meglio come giornalismo. La spiegazione metafisica è che Roger Federer è uno di quei rari atleti preternaturali che sembrano dispensati, almeno in parte, da certe leggi della fisica. Di questa categoria fanno parte Michael Jordan, che non solo saltava ad altezze disumane ma riusciva anche a rimanervi sospeso per una o due battute in più di quanto consenta la gravità, e Muhammad Ali, che letteralmente «fluttuava» sul ring e nel lasso di tempo necessario ad assestare un jab riusciva a piazzarne il triplo. Ci sono probabilmente una mezza dozzina di altri esempi che si potrebbero portare dal 1960 a oggi. E Federer è di questa specie – una specie che si potrebbe definire dei geni, o mutanti, o avatar. Non è mai in affanno o sbilanciato. La palla in avvicinamento resta sospesa in aria, per lui, una frazione di secondo in più di quanto dovrebbe. I suoi movimenti sono sciolti invece che possenti. Come Ali, Jordan, Maradona e Gretzky, Federer sembra al contempo meno e più solido dei suoi avversari. Soprattutto nella tenuta rigorosamente bianca che Wimbledon, non senza una certa compiaciuta soddisfazione, riesce ancora a imporre, Federer sembra ciò che in effetti potrebbe (a mio avviso) essere: una creatura dal corpo che è insieme di carne e, in qualche modo, di luce. Quanto alla palla che collabora e resta sospesa, rallentando la corsa, come influenzata dalla volontà dello svizzero, qui c’è un’autentica verità metafisica. Come nell’aneddoto seguente. Dopo la semifinale del 7 luglio, durante la quale Federer aveva distrutto Jonas Björkman – non battuto, distrutto – e appena prima della conferenza stampa, dove Björkman, che è amico di Federer, avrebbe detto di ritenersi fortunato ad «aver avuto il posto migliore dello stadio» per vedere lo svizzero «giocare quanto più vicino alla perfezione sia possibile», Federer e Björkman ridono e scherzano, e Björkman gli chiede quanto più grande del normale era oggi per lui la pallina, al che Federer gli risponde che era «come una palla da bowling, o da basket».
(da Roger Federer come esperienza religiosa, di David Foster Wallace, Edizioni Casagrande, 2010. Traduzione di Matteo Campagnoli. Qui l’articolo originale di Wallace pubblicato dal New York Times)
Se non sbaglio, questa edizione del libro è fuori commercio. In ogni caso, potete trovare il saggio su Federer in Il tennis come esperienza religiosa (Einaudi Stile libero Big, 2012) che ne contiene un altro, sempre di Wallace, dal titolo Democrazia e commercio agli US Open.
Nient’altro che uno specialista (seconda parte)
Visto che ho seri problemi ad incorporare il codice, per chi ha tempo da perdere ecco il link al terzo “storify” .
Nient’altro che uno specialista: il processo ad Adolf Eichmann e la banalità del male
 Il processo ad Adolf Eichmann – gerarca nazista fra i maggiori responsabili della Shoah– è stato uno dei momenti chiave del Novecento. Non tanto per la portata storica dell’evento, comunque gigantesca, quanto per la feroce disputa intellettuale che quel processo finì per suscitare in seno alla comunità ebraica. Già 15 anni prima, a Norimberga, il mondo aveva saputo e le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale condannato. I conti con la Germania nazista erano dunque chiusi ma le vittime delle persecuzioni erano rimaste fuori dalla corte giudicante e lo stesso sterminio degli ebrei era stato processato insieme agli altri crimini commessi dal Terzo Reich. Nel 1948 nasce lo Stato d’Israele e con gli anni cresce nel popolo ebraico la sete di giustizia, di una giustizia autodiretta che isolasse la Shoah dagli altri orrori della seconda guerra mondiale, dandole un significato e un peso autonomi.
Il processo ad Adolf Eichmann – gerarca nazista fra i maggiori responsabili della Shoah– è stato uno dei momenti chiave del Novecento. Non tanto per la portata storica dell’evento, comunque gigantesca, quanto per la feroce disputa intellettuale che quel processo finì per suscitare in seno alla comunità ebraica. Già 15 anni prima, a Norimberga, il mondo aveva saputo e le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale condannato. I conti con la Germania nazista erano dunque chiusi ma le vittime delle persecuzioni erano rimaste fuori dalla corte giudicante e lo stesso sterminio degli ebrei era stato processato insieme agli altri crimini commessi dal Terzo Reich. Nel 1948 nasce lo Stato d’Israele e con gli anni cresce nel popolo ebraico la sete di giustizia, di una giustizia autodiretta che isolasse la Shoah dagli altri orrori della seconda guerra mondiale, dandole un significato e un peso autonomi.
Nel 1960, grazie alle informazioni fornite da Simon Wiesenthal, il Mossad scova Eichmann in Argentina e lo rapisce per sottoporlo a giudizio in Israele.
Processando Heichmann, Israele annunciava al mondo che esisteva, che aveva il diritto di esistere, e che quel diritto era emerso come una necessità morale dalle macerie dei ghetti e dei campi di sterminio (da questo punto di vista deve essere letta la decisione di trasmettere il processo in tv). Il processo fu per gli ebrei l’occasione della nemesi, e attraverso questa, della catarsi: il dramma della Shoah usciva così dalla dimensione privata del ricordo per diventare tragedia collettiva e fondamento del nuovo Stato. Ma quell’evento finì per assumere una dimensione universale, quasi filosofica, perché ad essere trascinato alla sbarra, insieme al gerarca nazista, fu il male assoluto, il concetto stesso di malvagità sul quale l’uomo s’interroga da sempre, sforzandosi di afferrarne natura e radici. La domanda che permeava l’aula del tribunale, confusa tra le arringhe del pubblico ministero Gideon Hausner e le testimonianze dei sopravvissuti ai lager, era una soltanto: come è stato possibile, come ha potuto un uomo del genere commettere tali atrocità?
A Gerusalemme, nel 1961, il Male sedeva tranquillo in una gabbia di vetro e tutti videro che si trattava di un uomo occhialuto, magro, dal volto affilato, che soffriva di un’estesa calvizie, pacato nell’eloquio e composto nelle maniere.
La “soluzione finale” fu un’immensa e disumana macchina di morte che per essere efficace ed efficiente bisognava di una logistica perfetta, tanto crudele quanto pianificata fin nei minimi dettagli. Eichmann era uno dei gangli indispensabili dell’ingranaggio, organizzava il traffico dei treni che strappavano gli ebrei alle loro case e alle loro vite per condurli verso i campi di concentramento e le camere a gas. Dai suoi colleghi era soprannominato “lo specialista” , per l’esperienza accumulata nella gestione dei flussi migratori coatti. Nel corso delle udienze spiegò che non aveva mai odiato gli ebrei, ma che aveva soltanto fatto il suo lavoro, eseguendo ordini superiori ai quali non poteva disobbedire. Nessuno riusciva a credere che il Male potesse avere il volto di un grigio funzionario di Stato, di un uomo di mezz’età in giacca e cravatta che si alzava rispettosamente in piedi ogni volta che era chiamato a rispondere alle domande dell’accusa.
A seguire il processo come inviato del New Yorker c’era Hannah Arendt e quello che scrisse a proposito di Eichmann non poteva essere più sconvolgente. Il Male non ha nulla di diabolico, ma apparenza e sostanza ordinarie; non si serve di mostri né ha bisogno di condizioni estreme per compiersi. Il Male si nutre dell’assenza di pensiero: quando smette di pensare, di riflettere sul significato delle proprie azioni, quando soffoca la coscienza sotto il comando dell’autorità, anche l’uomo comune può macchiarsi dei crimini più efferati.
L’intellettuale tedesca rispondeva a quella domanda rimasta in sospeso come nessuno si sarebbe mai aspettato che facesse, e allo stesso tempo diffidava gli ebrei dal credere che compito del processo fosse quello di rimediare ai torti subiti. La corte doveva giudicare le azioni di Eichmann, nient’altro. Nell’esercizio della Legge e nella pratica della politica i sentimenti offuscano le capacità di raziocinio, l’odio rischia sempre di trasformare la vittima in aguzzino, di assottigliare il confine fra giustizia e vendetta.
Eleggere il pensiero a ragione di vita e a guida del nostro agire, mentre proprio il vuoto di pensiero emergeva come la principale causa della deriva morale di un secolo che stava mettendo a rischio la sopravvivenza stessa del genere umano. E’ grazie ad Hannah Arendt se abbiamo colto il senso universale di quei giorni, se le sue parole risuonano tutt’ora come una minaccia da scolpire nelle nostre teste: esistono miliardi di Heichmann e tutto può tornare a succedere.
Il reportage fu pubblicato in cinque parti sul New Yorker, dal 16 febbraio al 16 marzo del 1963, a due anni dal processo. Gli articoli confluirono in un libro, Eichmann in Jerusalem. A Report on the banality of the Evil, pubblicato in Italia da Feltrinelli (1964) a titolo invertito.
L’uscita degli articoli scatenò una furiosa controversia intellettuale, che si accese soprattutto dentro la comunità ebraica di New York – dove l’intellettuale tedesca era emigrata per sfuggire ai nazisti – assumendo per dimensioni e ferocia i contorni di una guerra civile senza spargimenti di sangue. Presa tra due fuochi, Hannah fu accusata di tutto, persino di voler compiacere Heidegger – suo professore di filosofia all’università di Marburgo e in seguito suo amante segreto – che mai ripudiò il credo nazionalsocialista. Da un lato gli ebrei, che percepirono le pesanti accuse di collaborazionismo mosse dalla Arendt come un tradimento e il ritratto di Eichmann come una profanazione; dall’altro gli americani che, scambiando lucciole per lanterne, non le perdonarono un atteggiamento nei confronti dei tedeschi ritenuto troppo accondiscendente e il giudizio tutt’altro che positivo sullo stesso sionismo che gli Stati Uniti avevano foraggiato e che aveva condotto alla formazione di Israele.
Così Hannah Arendt rispose ad una lettera di Gershom Sholem, illustre studioso del misticismo ebraico che, dopo aver letto il libro, l’aveva incolpata di essere stata troppo dura con gli ebrei e di non amare abbastanza il suo popolo:
Hai perfettamente ragione, non sono animata da nessun “amore” di questo genere, e ciò per due ragioni: nella mia vita non ho mai “amato” nessun popolo o collettività. Io amo “solo” i miei amici e la sola specie di amore che conosco e in cui credo è l’amore per le persone. In secondo luogo, questo “amore per gli ebrei” mi sembrerebbe, essendo io stessa ebrea, qualcosa di piuttosto sospetto. Non posso amare me stessa o qualcosa che so essere una parte essenziale della mia persona.
Su questa controversia è incentrato Hannah Arendt, un film diretto da Margarethe Von Trotta – già regista di pellicole basate sulla storia di donne scomode ed eccezionali (Rosa L. , su Rosa Luxemburg; Vision, su Ildegarda di Bingen) – con Barbara Sukowa nel ruolo della pensatrice tedesca. Il film ha esordito nel settembre 2012 al “Toronto International Film Festival” ed è già uscito in vari paesi europei, fra cui Germania, Francia, Stati Uniti, Israele, Spagna. In Italia non è ancora stato distribuito e forse mai lo sarà. (Non avevo verificato bene quest’ultima informazione e mi rendo conto di essere un inguaribile pessimista. Il film è già stato proiettato nell’ambito del “Bari International Film Festival” , che si è tenuto dal 16 al 23 marzo di quest’anno, e dovrebbe approdare nei cinema italiani in autunno, distribuito dalla Ripley’s Film. Semplicemente, come accade spesso, le cose da noi arrivano sempre più tardi.)
Non sono riuscito ancora a vederlo ma se un giorno dovessi farcela ne scriverò di certo su questo blog.
Nei prossimi post continuerò a toccare l’argomento, anche perché ho un po’ di cose interessanti da segnalarvi che, aggiunte qui, allungherebbero troppo il discorso. Nel frattempo vi lascio con El hombre sin cualidades, un articolo di Vargas Llosa pubblicato da El Pais nella sua versione digitale. Lo scrittore peruviano prende lo spunto dal film di Margarethe Von Trotta per soffermarsi – citando Musil – sulla figura del grigio burocrate dipinta dalla pensatrice tedesca.
Vale la pena riportarne qualche passaggio:
[…] La rigorosa autopsia a cui Hannah Arendt sottopone Adolf Eichmann, braccio destro di Himmler ed uno dei più eminenti specialisti hitleriani del “problema ebraico”, o per la precisione, dello sterminio di 6 milioni di ebrei europei, sulla base dei documenti e delle testimonianze esibiti durante il processo, porta ad una conclusione agghiacciante e valida non solo per il nazismo ma per tutte le società degradate dal servilismo e dalla codardia che un regime totalitario genera nella popolazione. Lo spirito romantico, connaturato all’Occidente, non si è mai liberato del pregiudizio che la fonte della crudeltà umana debba essere ricercata in personaggi diabolici, di statura terrificante, mossi dall’ideale perverso di far soffrire gli altri e seminare intorno a sé devastazione e lacrime. Niente di ciò si avvicina alla personalità di questo mediocre povero diavolo, che fallisce in tutto, incolto e stupido, che all’improvviso trova dentro la burocrazia nazista l’opportunità di avere successo e sfruttare il potere. Disciplinato più per negligenza che per convinzione, un istinto di sopravvivenza annulla in lui la capacità di pensare ai pericoli che potrebbero derivare dalle sue azioni, e quando ce n’è bisogno sa obbedire e servire il suo capo con la docilità di un cane, coprendo i suoi occhi con una benda morale che gli consente di ignorare le conseguenze delle azioni che perpetra giorno dopo giorno […] Durante il processo, Eichmann affermò con enfasi di non aver mai ucciso un ebreo di propria mano e sicuramente non mentiva.
Chiunque abbia patito una dittatura, anche la più leggera, ha potuto verificare che il sostegno più solido di questi regimi che cancellano la libertà, la critica, l’informazione senza paraorecchie e che si beffano dei diritti umani, sono questi individui senza qualità, burocrati per professione e per anima, che muovono le leve della corruzione e della violenza, delle torture e dei soprusi, dei furti e delle scomparse, guardando senza vedere, sentendo senza ascoltare, agendo senza pensare, trasformati in automi viventi che, in questo modo, come capitò ad Eichmann, riescono a scalare le posizioni più alte. Invisibili, efficaci, da questi nascondigli che sono i loro uffici, queste mediocrità senza volto e senza nome che pullulano in ogni dittatura, sono sempre i responsabili delle peggiori sofferenze e orrori che quella produce, gli agenti di questo male che, spesso, invece di adornarsi della munificenza di un Belzebù, si nasconde sotto la banalità di un oscuro funzionario. […]
Passi d’autore #10: Victor Hugo
 Stava in piedi sulla gradinata di ciottoli, con un gomito appoggiato alla carabina, immerso nei suoi pensieri, e trasaliva, come se passassero degli aliti di vento. I luoghi dove sta la morte producono simili sensazioni da tripode. Dalle sue pupille, animate da uno sguardo interiore, uscivano come dei bagliori soffocati. D’improvviso alzò la testa, e i suoi biondi capelli rovesciati all’indietro come quelli dell’angelo sulla tetra quadriga di stelle, parevano la criniera di un leone scompigliata in una fiammeggiante aureola.
Stava in piedi sulla gradinata di ciottoli, con un gomito appoggiato alla carabina, immerso nei suoi pensieri, e trasaliva, come se passassero degli aliti di vento. I luoghi dove sta la morte producono simili sensazioni da tripode. Dalle sue pupille, animate da uno sguardo interiore, uscivano come dei bagliori soffocati. D’improvviso alzò la testa, e i suoi biondi capelli rovesciati all’indietro come quelli dell’angelo sulla tetra quadriga di stelle, parevano la criniera di un leone scompigliata in una fiammeggiante aureola.
Disse:
<<Cittadini, vi figurate l’avvenire? Le vie della città inondate di luce, rami verdi sulle soglie, le nazioni sorelle, gli uomini giusti, i vecchi che benedicono i fanciulli, il passato che ama il presente, i filosofi pienamente liberi, i credenti del tutto eguali, per religione il Cielo, per sacerdote Dio, la coscienza umana trasformata in altare, gli odi svaniti, fratellanza di fabbrica e di scuola, la fama per pena e ricompensa, a tutti il lavoro, per tutti il diritto, su tutti la pace, non più spargimento di sangue, né guerre, madri felici! Il primo passo sta nel domare la materia, il secondo nel realizzare l’ideale. Riflettete a quanto il progresso ha già compiuto. Anticamente le prime razze umane vedevano con terrore dinanzi ai loro occhi l’idra che soffiava sulle acque, il drago che eruttava fuoco, il grifone, il mostro dell’aria che volava con ali di aquila e artigli di tigre; bestie spaventose che stavano al di sopra dell’uomo. Ma l’uomo ha teso i suoi agguati, le sacre insidie dell’intelligenza, e ha finito per impadronirsi dei mostri.
Abbiamo domato l’idra e la chiamiamo battello a vapore, abbiamo domato il drago e si chiama locomotiva: siamo vicini a domare il grifone, già quasi lo teniamo e si chiama aerostato. Il giorno in cui quest’opera da Prometeo sarà compiuta, quando l’uomo avrà definitivamente aggiogato alla sua volontà la triplice chimera antica, l’idra, il drago e il grifone, sarà padrone dell’acqua, del fuoco e dell’aria; diventerà per la restante creazione ciò che gli antichi dèi erano per lui. Coraggio e avanti! Dove andiamo, cittadini? Alla scienza fatta governo, alla forza delle cose diventata la sola forza pubblica, alla legge naturale contenente in se stessa le sue sanzioni e le sue pene e si promulga con l’evidenza, a un sorgere della verità che somiglia allo spuntare dell’aurora. Noi procediamo verso l’unione dei popoli, verso l’unità dell’uomo. Non più finzioni, non più parassiti. La realtà diretta della verità, ecco lo scopo. La civiltà terrà le sue Assise al culmine dell’Europa, e più tardi al centro dei continenti, nel gran parlamento dell’intelligenza.
Già si vide qualcosa di simile. Gli anfizioni tenevano due sedute all’anno, una a Delfo, sacra agli dèi, l’altra alle Termopili, sacra agli eroi. L’Europa avrà i suoi anfizioni, li avrà l’intero globo; la Francia porta in seno questo sublime avvenire, che è la gestazione del secolo decimonono. Ciò che fu sbozzato dalla Grecia è degno di essere compiuto dalla Francia. Ascoltami, Feuilly, valente operaio, uomo del popolo, anzi dei popoli; io ti venero. Sì, tu vedi chiaramente il futuro; tu hai ragione. Tu non avevi né padre, né madre, e hai adottato per madre l’umanità , per padre il diritto. Tu stai per morire qui, vale a dire per trionfare. Qualsiasi cosa avverrà oggi, tanto la sconfitta come la vittoria, noi qui compiremo una rivoluzione. Come gli incendi rischiarano un’intera città, le rivoluzioni illuminano tutto il genere umano. E quale rivoluzione faremo? Già ve lo dissi, quella del Vero.
Dal punto di vista politico c’è un solo principio, la sovranità dell’uomo su se stesso. Questa sovranità dell’io sull’io si chiama Libertà. Quando due o parecchie di queste sovranità si associano, comincia lo Stato. Ma nella loro associazione non c’è abdicazione; ciascuna sovranità cede un po’ di se stessa per formare il diritto comune, la medesima quantità per tutti; tale identità di cessione, fatta da ciascuno a tutti, si chiama Uguaglianza. Il diritto comune si risolve nella protezione di tutti diffusa sul diritto di ciascuno; e la protezione di tutti a ciascuno si chiama Fratellanza. Il punto di confluenza di tutte le sovranità che vengono ad aggregarsi, si chiama Società. La confluenza implica la connessione, per cui quel punto è un nodo; da ciò quel che si chiama il vincolo sociale. Alcuni dicono contratto sociale; ma è la stessa cosa derivando il termine contratto etimologicamente dall’idea di legame.
Giova intendersi bene sull’Uguaglianza, perché se la Libertà è la cima, l’Uguaglianza è la base. L’Uguaglianza, o cittadini, non vuol dire una vegetazione che debba giungere tutta a un medesimo livello, una società di giganteschi fili d’erba e di querce nane, una vicinanza di gelosie che s’intralciano a vicenda; ma significa civilmente che tutte le attitudini trovino la stessa facilità di sviluppo; politicamente, che tutti i voti abbiano il medesimo peso; religiosamente, che tutte le coscienze ottengano lo stesso diritto. L’Uguaglianza ha un organo; l’istruzione gratuita e obbligatoria. Bisogna cominciare dal diritto all’alfabeto. La scuola primaria imposta a tutti, la secondaria offerta a tutti, ecco la vera legge. Dalla scuola identica esce la società uguale. Insegnamento! Luce! Luce! Tutto viene dalla luce e tutto vi ritorna.
Cittadini, il diciannovesimo secolo è grande, ma il ventesimo sarà felice. Allora non ci sarà nessuna somiglianza con la storia antica; non si dovrà più temere, come oggi, conquiste, invasioni, usurpazioni, rivalità armate tra popoli, interruzioni della civiltà cagionate dal matrimonio di un re, nascite nelle tirannie ereditarie, spartizioni di popoli decise da un congresso, smembramenti per il crollare di una dinastia, zuffe tra religioni che cozzano come due arieti nell’ombra sul ponte dell’infinito; non si dovrà più temere la carestia, lo sfruttamento, la prostituzione causata dalla fame, la miseria prodotta dalla mancanza di lavoro, e il patibolo, e la spada, e le battaglie, e tutte le rapine del caso nella selva degli eventi. Si potrebbe quasi dire che non vi saranno più eventi. Vivranno tutti felici. Il genere umano adempirà alla propria legge, come il globo terrestre alla sua; si ristabilirà l’armonia tra l’anima e l’astro, e quella graviterà intorno alla verità, come questo intorno alla luce.
Amici, l’ora in cui ci troviamo, in cui vi parlo, è tetra, ma è il terribile prezzo dell’avvenire. Una rivoluzione è un pedaggio. Oh, sì! Il genere umano verrà liberato, rialzato, confortato! Glielo giuriamo noi su questa barricata. E da dove lanceremo il grido d’amore se non dall’alto del sacrificio? Fratelli miei, è questo il luogo dove convengono quelli che pensano con quelli che soffrono; questa barricata non è costruita di sassi, di travi, di ferramenta; ma di due mucchi: uno di idee, l’altro di dolori. La miseria qui si incontra con l’ideale: qui il giorno abbraccia la notte e le dice: “Io muoio con te e tu rinascerai con me” . Dall’abbraccio di tutte le desolazioni, scaturisce la fede. I patimenti portano qui la loro agonia, e le idee la loro immortalità; e tale agonia, tale immortalità, stanno per congiugersi e comporsi nella nostra morte. Fratelli, chi muore qui, muore nell’irradiamento dell’avvenire; e noi entriamo in una tomba dove già penetra l’aurora>>.
Enjolras s’interruppe più che tacere; le sue labbra continuarono ad agitarsi silenziosamente come se parlasse fra sé, per cui tutti rimasero intenti a osservarlo, sforzandosi di udirlo ancora. Non vi furono applausi, ma continuò per qualche tempo un lungo mormorio. La parola è un soffio, e i fremiti delle intelligenze somigliano a quelli delle foglie.
(da I miserabili, 1862. Traduzione di E. De Mattia)